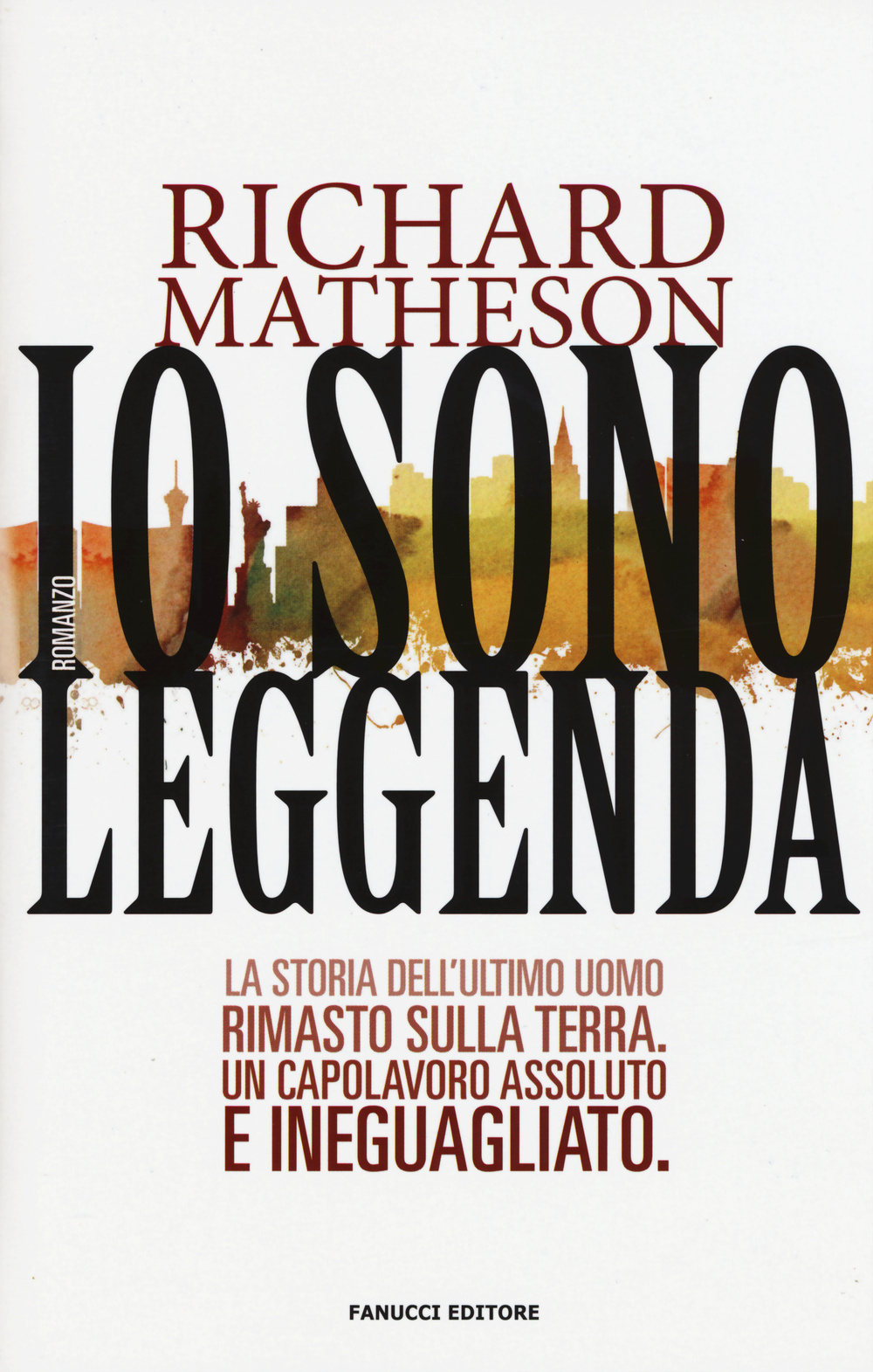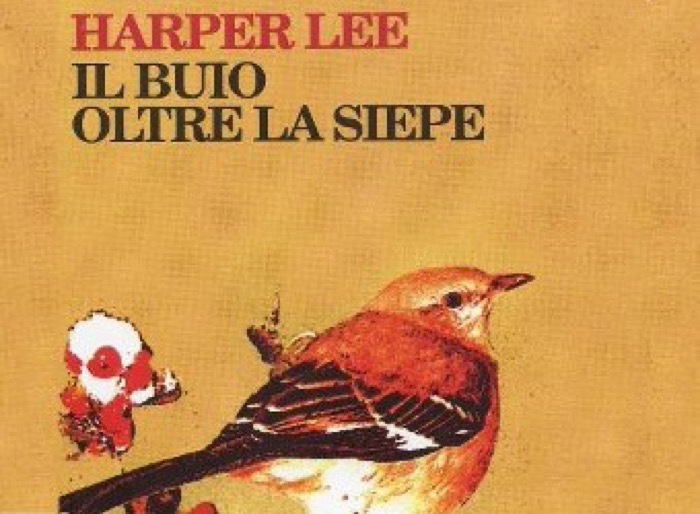"Stenderò il mio rapporto come se fosse una storia. Mi è stato insegnato, quand'ero bambino, sul mio pianeta natale, che la Verità è una questione di immaginazione" U.K.Le Guin - La mano sinistra delle tenebre
domenica 24 aprile 2022
Le cose crollano - l'alba della letteratura africana moderna
domenica 16 maggio 2021
La svolta degli audiolibri + Doppio Sogno – Piovono Libri
martedì 6 aprile 2021
Lampi di luce dalla zona rossa
Pare che, per il Piemonte, la prospettiva migliore sia uscirne per fine mese.
Se non altro domani le scuole fino alla prima media riapriranno. Non fraintendetemi, non sono di quelle che vogliono la scuola aperta sempre e comunque a ogni condizione. A ottobre/novembre, ad esempio, una chiusura sarebbe stata auspicabile. Ma adesso, almeno nella zona dove lavoro io, tutto il personale docente ha avuto almeno una dose di vaccino (che non dà l'immunità perché per entrare a regime bisogna attendere qualche settimana dalla seconda dose, ma è comunque meglio di niente). E, sopratutto, le attività produttive non hanno chiuso. Quindi i bambini, la mia compresa, hanno in media frequentato più gente diversa di quanto facessero andando a scuola, sballottati tra nonni, baby sitter e parenti vari, individui fragili compresi. Bastava sentire qualche alunno di DaD "scusi, la rete non regge, ci sono qui anche i miei quattro cugini e i due vicini di casa, visto che la nostra connessione è la migliore...". Mia figlia stava in parte con me, in parte con un baby sitter, in parte con i nonni, in parte con gli zii, insomma, un inevitabile delirio di contatti che, a livello di mero rischio, mi è sembrata una cura peggiore del male.
Io me la sono passata tutto sommato meno peggio del previsto. Il mio baby sitter è stato catturato al momento giusto, la scuola è riuscita a garantire ai docenti genitori la possibilità di lavorare da casa almeno per alcuni giorni a settimana, garantendo allo stesso tempo la possibilità di frequenza per gli alunni con bisogni educativi speciali. Ai ragazzi era stato dato il famoso ipad/astronave in comodato d'uso, cosa che ha almeno garantito a tutti un mezzo pratico e resistente per la DaD. Nulla si è potuto fare per le connessioni più ballerine che, in una zona di paesini sparsi tra boschi e colline di granito, hanno poco a che fare con la volontà di famiglie e istituzioni. Come l'anno scorso eravamo in mano a Eolo, inteso non come fornitore di servizi, ma proprio come dio dei venti, perché col brutto tempo nei paesini internet non va e in molti giorni la rete sembra più che altro alimentata a bestemmie. Quindi abbiamo ripreso il balletto del ti vedo/non ti vedo/vedo solo il soffitto/vedo solo il tuo gatto. Devo dire però che gli animali domestici, i miei compresi, sono stati tutti disciplinati e hanno seguito le lezioni con una certa costanza.
Questo ovviamente non ha impedito scene al limite del delirio, come avere la figlia in crisi di nostalgia per l'asilo e gli amichetti in piena ora di geografia, consolata poi dai miei alunni in DaD (ho ancora il dubbio se firmarla come educazione civica). Peggio ancora, un increscioso incidente con il vasino in un'ora non coperta dal baby sitter. La mia spiegazione è stata una cosa del tipo "... Quindi il carattere di Ulisse è caratterizzato dalla curiosità... Ok, ragazzi, spengo la telecamera un attimo... E dall'intelligenza... Eh, ma qui c'è pipì ovunque... E dal sapersela cavare in ogni occasione... Evitiamo almeno di metterci i piedi dentro...". Ovviamente queste settimane di DaD sono state anche le settimane dei colloqui con i genitori, dei consigli di classe, del cambiamento di lavoro del marito... Tutto sommato l'esserne usciti vivi ha del miracoloso.
Sono state anche le settimane in cui qui in Piemonte la campagna vaccinale ha finalmente ingranato. I suoceri hanno ricevuto entrambi la prima dose, mia mamma sta smaltendo i postumi della sua unica somministrazione. Mio padre è stato rimandato a data da destinarsi per aver da poco fatto un'anestesia totale, ma ha fatto la conta degli anticorpi, li ha ancora talmente alti che è stato chiamato per partecipare a uno studio sulle varianti (di cui onestamente ho capito poco, ma va bene così). Da oggi, poi, sono state aperte le prenotazioni anche per la fascia d'età 60-69 anni. Tutte le vaccinazioni sono state eseguite nel punto di somministrazione più vicino al domicilio e al momento tutti parlano di gentilezza e professionalità da parte del personale. Per la prima volta sembra davvero che qualcosa si stia muovendo nella direzione giusta. Spero solo di non illudermi.
Spero ora di rimettermi sui binari di ritmi più sostenibili, che mi permettano, tra le altre cose, di continuare ad vivere il blog e a leggere i post altrui. Questo spazio esiste da un sacco di tempo e mi scoccerebbe davvero perderlo per una cosa futile come una pandemia, insomma!
In queste settimane di stop ho anche saltato l'abituale rubrica "piovono libri" dedicata ai classici letti col gruppo di lettura. Anche se solo poche righe, però, il libro del mese le merita.
domenica 17 gennaio 2021
Il castello dei destini incrociati – Piovono libri
 |
| – Idea fotografica rubata a Elena – |
domenica 13 dicembre 2020
Io sono leggenda – Piovono libri
A mia discolpa posso dire che sono cinque anni che propongo questo romanzo. La scelta del libro da leggere avviene tramite una doppia estrazione e poi per votazione tra i due titoli. Che io ricordi Io sono leggenda non era mai stato estratta e io (l'ho già detto che sono testarda?) l'ho puntualmente riproposto ogni settembre. Fatalmente è arrivato il suo momento nel pieno della seconda ondata.
Io sono leggenda tornato agli onori della cronaca tredici anni or sono per una trasposizione cinematografica che, letto l'originale, ci azzecca poco, infatti, è un romanzo del 1954 che parte dal racconto di una pandemia.
domenica 15 novembre 2020
Lamento di Portnoy – Piovono Libri (e chiacchiere varie)
domenica 18 ottobre 2020
Signorina Else – Piovono Libri
mercoledì 5 febbraio 2020
Racconti di pioggia e di luna – Piovono Libri
sabato 26 ottobre 2019
Il buio oltre la siepe – Piovono Libri
giovedì 26 settembre 2019
Comma 22 – Piovono libri
sabato 15 giugno 2019
Un amore – Piovono Libri
lunedì 1 aprile 2019
Finzioni – Piovono libri
E forse, in un qualche modo, viviamo davvero nella Lotteria di Babilonia, dove tutto è stabilito dal caso e non ci resta, per trovare un ordine, che costruirci un universo regolato e fittizio in testa. E fingere che sia vero.
lunedì 18 febbraio 2019
L'abbazia di Northanger – Piovono libri
Sono, in effetti, particolarmente interessanti tutti i riferimenti al mondo dell'editoria, così simile al nostro. Un mondo interessato solo a ciò che vende, nella fattispecie, quindi, romanzetti gotici, in cui un romanzo di valore può essere opzionato da un editore e mai edito e mai pagato. Vi ricorda qualcosa?
Consigliatissimo, dunque, sia a chi della Austen ha già letto le opere più famose, sia a chi associa il nome solo a storie romantiche a cui non si avvicinerebbe mai.
 |
| "Stupidi umani, che avete bisogno di specchiarmi nei libri per guardare il mondo, smettetela con le chiacchiere e onoratemi come merito!" |
lunedì 29 ottobre 2018
Colazione da Tiffany – Piovono Libri
venerdì 5 ottobre 2018
Padrone del tuo destino – racconto a puntate, capitolo 2
Il capitolo è lungo, ma a spezzarlo mi pareva di fare più male che bene.
– Capitolo 1